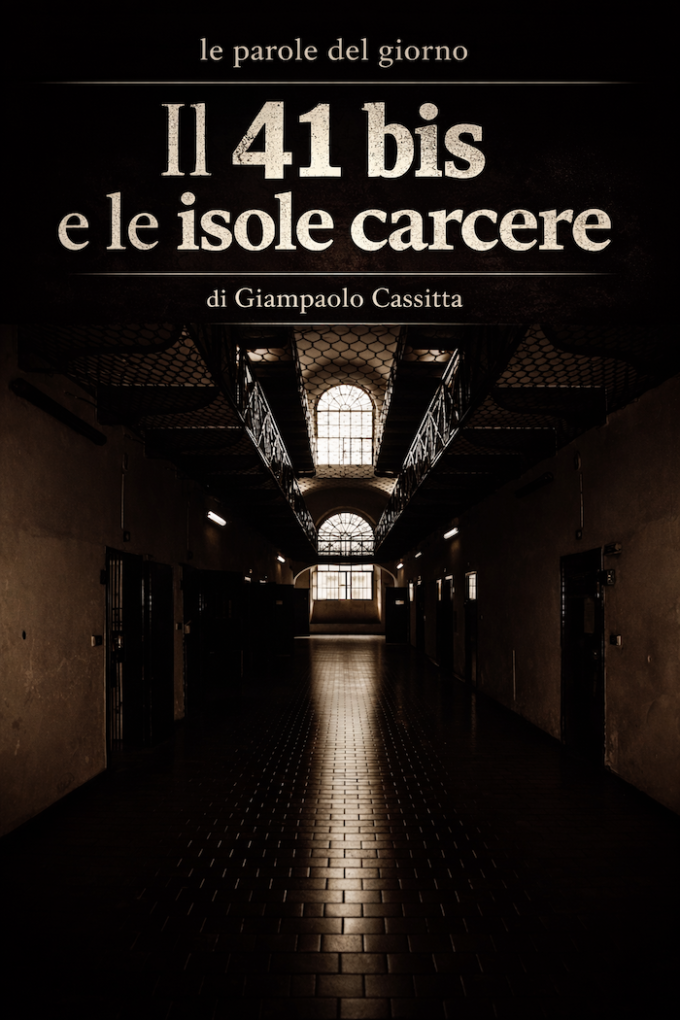
La richiesta di mobilitazione avanzata dalla presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde contro la decisione del Governo sulla futura distribuzione dei detenuti in regime di 41 bis nell’isola non è una notizia amministrativa. È un atto politico nel senso più alto e più tragico del termine. È una crepa, finalmente visibile, nel muro di ipocrisia con cui da decenni la politica italiana copre il carcere, fingendo che non esista finché non diventa ingestibile, esplosivo, mediaticamente pericoloso. Si parla di carcere solo quando c’è urgenza, e in questo Paese l’urgenza è diventata un alibi permanente: tutto è emergenza, dunque nulla è mai responsabilità.
Ma proprio perché tutto viene ridotto a emergenza, è arrivato il momento di dire le cose con una brutalità che non lasci spazio a fraintendimenti. La Sardegna non è una discarica penale. Non è un contenitore geografico dove stipare ciò che lo Stato non sa, non vuole, non ha il coraggio di governare. L’idea che l’isola possa assorbire la delinquenza nazionale, fungere da ventre oscuro in cui nascondere il problema, non nasce oggi. È un’idea antica, ottusa, profondamente autoritaria. È l’idea del potere quando rinuncia a capire e sceglie di espellere.
Il potere, quando è incapace di analizzare la devianza, di affrontare il conflitto sociale, di interrogarsi sulle proprie responsabilità, ricorre sempre allo stesso trucco: l’isolamento. Isolare i corpi per non dover ascoltare le voci. Isolare le persone per non dover fare i conti con le cause. Che si tratti di delinquenti comuni o di oppositori politici, poco importa: il meccanismo è identico, la logica è la stessa, l’odore è quello stantio dell’autoritarismo travestito da sicurezza.
L’isola è perfetta per questo gioco sporco. Circondata dall’acqua, apparentemente naturale, apparentemente neutra, l’isola diventa una macchina penale formidabile. Il mare come muro, l’orizzonte come scherno quotidiano, la distanza come strumento di annientamento. Non è una novità storica, non è una peculiarità italiana. Il mondo intero è disseminato di isole trasformate in luoghi di espulsione morale prima ancora che fisica. Robben Island, la Baia dei Santi nella Guyana francese, l’Isola del Diavolo, Alcatraz: nomi che non indicano soltanto luoghi, ma un’idea precisa di potere, quella che confonde la giustizia con la sottrazione, la pena con la rimozione.
In Italia questa ossessione ha assunto una forma quasi patologica. Il mare non è mai stato solo un confine, è stato un alleato della repressione. Dalle colonie penali ottocentesche al confino fascista, fino alle carceri speciali del secondo Novecento, le isole hanno funzionato come una pena aggiuntiva, una condanna che precede e accompagna quella scritta nelle sentenze. L’isolamento geografico si è sommato a quello giuridico ed esistenziale, producendo luoghi dove il tempo si ferma e la persona si dissolve.
Santo Stefano e Ventotene non sono soltanto nomi scolpiti nella storia. Sono la dimostrazione plastica di come il potere tenti di spegnere il dissenso e finisca, talvolta, per concentrarlo, per renderlo più consapevole, più radicale. Lì il confino non era solo una misura di polizia, era un laboratorio di controllo politico, una pedagogia autoritaria che credeva di poter rieducare attraverso la distanza. Pianosa, l’Asinara, Favignana, Lipari raccontano la stessa storia con accenti diversi: l’illusione che basti allontanare per risolvere, separare per governare, nascondere per pacificare.
Ma il potere, quando sceglie l’isola, confessa la propria miseria. Confessa di non saper parlare, di non voler ascoltare, di non avere una visione. Decidere senza confronto, senza coinvolgere i territori, senza ascoltare chi è stato eletto democraticamente, non è forza. È debolezza allo stato puro. È paura mascherata da decisionismo.
Sul 41 bis il Governo non ha risposte vere, e questo è evidente. Ma ciò che è ancora più grave è che non ha risposte sul carcere nel suo insieme. Nessuna pianificazione seria, nessuna idea di lungo periodo, nessuna riflessione sulla funzione della pena in una democrazia che si proclama civile. Solo spostamenti, redistribuzioni, emergenze amministrate come se fossero fatalità naturali.
La Sardegna, oggi, non sta solo difendendo se stessa. Sta ponendo una domanda che riguarda tutti: vogliamo continuare a usare il carcere come luogo di espulsione morale, o abbiamo il coraggio di guardarlo in faccia come uno specchio del nostro fallimento collettivo? Perché ogni isola-carcere, ogni decisione presa nel silenzio, ogni detenuto allontanato per non disturbare, dice molto meno di loro e infinitamente di più di noi. Credo sia necessario, oggi più che mai un bel dibattito pubblico non solo sul carcere duro o speciale, ma sul carcere in senso lato e sulle prospettive che il carcere ha in Sardegna.
E allora diciamolo senza attenuanti, senza il linguaggio asettico dei comunicati, senza la viltà delle perifrasi: qui non è in gioco la sicurezza, ma la coscienza di uno Stato. Un potere che usa le isole per allontanare ciò che non vuole vedere è un potere che ha smesso di pensare. È un potere che non governa, amministra il proprio vuoto. Il carcere, così concepito, non è più pena né giustizia, è solo una tecnica di rimozione, un gesto antico e primitivo, come gettare i rifiuti oltre l’orizzonte sperando che il mare li inghiotta. Ma il mare restituisce sempre tutto. Restituisce le colpe, le omissioni, le menzogne. E un giorno, non lontano, restituirà anche questa scelta, mostrando che non era necessità, ma comodità; non forza, ma paura. E allora non basteranno più le isole, né il silenzio, né l’emergenza permanente: resterà solo la nudità di uno Stato che, avendo rinunciato a capire, avrà rinunciato anche a essere giusto.
Chiedo alla presidente Todde, non da commentatore distratto, ma da cittadino che ha attraversato per 40 anni le stanze opache della pena, un confronto che non sia rituale né prudente. Un confronto aperto, civile, leale, soprattutto vero. Un confronto che abbia il coraggio di toccare ciò che tutti fingono di non vedere: il 41 bis come dogma intoccabile, l’eredità ambigua delle colonie penali, l’idea di un carcere che possa dialogare con il sapere attraverso poli universitari reali, il lavoro come dignità e non come concessione, la formazione della polizia penitenziaria sottratta alla sola logica dell’ordine, la presenza educativa come asse portante e non come ornamento marginale.
La Sardegna potrebbe diventare un laboratorio e non l’ennesimo esperimento punitivo deciso altrove. Un laboratorio politico nel senso più nobile, dove si prova a costruire invece di segregare, a capire invece di allontanare, a immaginare invece di reprimere. Un luogo in cui il carcere smetta di essere un buco nero e diventi, finalmente, una questione pubblica affrontata alla luce del sole.
Non è troppo tardi. Ma il tempo, come sempre, non aspetta chi ha paura di pensare.
Questo articolo è stato scritto il giovedì, Febbraio 5th, 2026 at 10:53
È possibile seguire tutte le risposte a questo articolo tramite il RSS 2.0 feed.
Posted in: Blog, le ragioni di Caino

